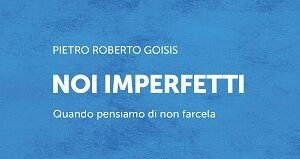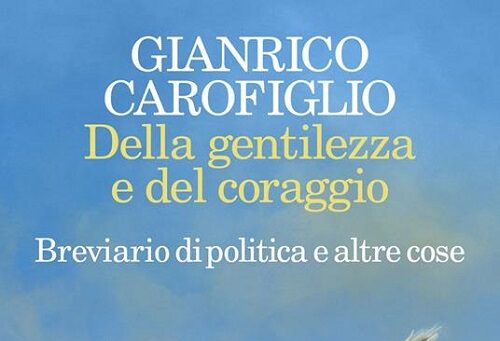Riporto una sintesi di alcuni passaggi di un’intervista di Paolo Mastrolilli a Cas Mudde professore della School of Public and International Affairs alla University of Georgia pubblicata su Repubblica il 29 gennaio 2024 che credo aiuti a capire meglio il funzionamento del pensiero di estrema destra sul ruolo della libera informazione e dei pericoli che i movimenti di questo tipo portano alle democrazie così come le abbiamo costruite nell’ultimo secolo. Spero possa illuminare quelli convinti per misteriose ragioni che l’estrema destra italiana abbia caratteristiche diverse – e meno preoccupanti – delle destre del resto del mondo.
Non hai tempo o voglia di leggere? Ascolta il testo!
Mudde, olandese, ha un curriculum di tutto rispetto e una lunga carriera come studioso di estremismo e populismo negli Stati Uniti e in Europa e, curiosamente è fratello di un noto politico di estrema destra olandese.
1
In primo luogo sottolinea come i movimenti di destra abbiano una visione omogenea dell’establishment, delineando il mondo in bianco e nero. La loro percezione dell’indipendenza dei media è altrettanto rigida: se ti schieri come “indipendente, sei automaticamente visto come un nemico”. In questa visione, non esiste una via di mezzo, o “stai con loro o sei contro di loro”.
2
Rispetto al ruolo del media, Cas Mudde segnala come riservino un’attenzione sproporzionata all’estrema destra, e con connotazioni generalmente negative. Il che però non significa automaticamente una informazione scorretta. Ma così viene vissuta in genere dagli esponenti dell’estrema destra. Mudde ricorda che, nonostante questa situazione, esistono ormai numerosi media che sostengono apertamente la destra, dalla Fox News negli Stati Uniti allo Spectator nel Regno Unito. Tuttavia, “la destra però ama interpretare il ruolo della vittima, e quindi si lamenta quando riceve un’attenzione sproporzionata”.
3
Interessante la spiegazione che il professore dà delle campagne contro i media: non sono solo manifestazioni di scontento, ma vere e proprie strategie politiche. Con uno scopo preciso: intimidire i media affinché diventino meno critici e, possibilmente, più inclini a simpatizzare con la loro causa. Un esempio evidente è rappresentato dalle recenti critiche della premier italiana Meloni nei confronti del quotidiano Repubblica. “Quando la premier italiana Meloni attacca Repubblica non vuole che scompaia, ma che scriva meglio del suo esecutivo “
4
Rispetto alla strategia della premier Meloni di evitare di rispondere direttamente alle domande e di sviare l’attenzione verso altri temi o di attaccare personalmente l’avversario o il giornalista che fa domande scomode, la spiegazione di Mudde è che notoriamente tutti i governi, in determinati momenti, debbano compiere azioni impopolari, talvolta in netta contraddizione con le promesse elettorali fatte. In queste situazioni, una strategia comune è quella del “deflect”, ovvero deviare l’attenzione dell’opinione pubblica. “Si fa in vari modi, ma il più comune è attaccare il messaggero per non discutere il messaggio”. Come sottolinea l’analista politico, questo approccio è ampiamente utilizzato, ad esempio da leader come Viktor Orbán in Ungheria e anche da Donald Trump negli Stati Uniti. Non è un’esclusiva della destra: anche la sinistra ricorre a tattiche simili, ma la destra sembra aver interiorizzato e fatta propria questa prassi come proprio modus operandi.
5
Arriviamo così al capitolo più spinoso. I rischi per la tenuta democratica.
Dimentichiamo le censure del passato che oggi non funzionerebbero e sarebbero interpretate come debolezze. La nuova strategia per erodere la democrazia e il libero scambio di informazioni è più sottile e insidiosa. La democrazia oggi non viene uccisa da un colpo di Stato, ma si erode progressivamente. Lo stesso accade con i media”. Una nuova forma di minaccia che combina elementi autoritari e neoliberisti, un modello inaugurato da leader come Vladimir Putin e ripreso da Viktor Orbán.
Invece di ricorrere a misure dirette come la chiusura dei giornali, si predilige l’uso dell’autocensura come strumento di controllo. I giornalisti vengono incentivati a fornire una copertura favorevole attraverso l’offerta di benefici o la minaccia di penalizzazioni finanziarie. In alcuni casi estremi, si arriva persino all’acquisizione di media ostili da parte di individui o gruppi vicini al potere politico, con il pretesto di problemi finanziari o mancanza di profitti. Fino a decretarne la chiusura proprio per mancanza di profitti. Questo approccio permette di esercitare una forma di censura mascherata, in cui il mercato stesso diventa strumento di eliminazione dei media indipendenti, mantenendo apparentemente intatta la facciata democratica.
“Così fa censura usando le regole della democrazia, – conclude Mudde – perché è il mercato ad eliminare i media, non il regime”.
Potrebbe interessarti anche: Una politica della speranza contro la paura – no alternative