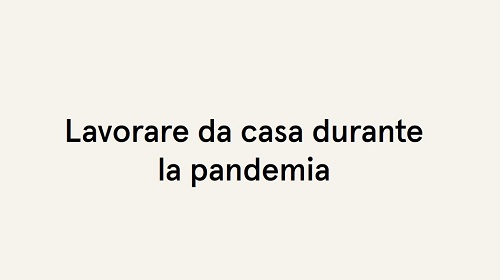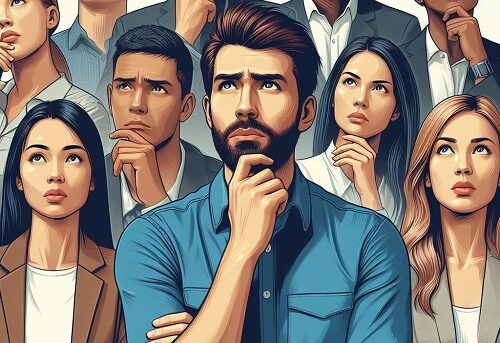Pubblico alcuni significativi estratti del primo capitolo del libro di Andrea Colamedici e Maura Gancitano “Ma chi me lo fa fare” dal titolo Arbeit Macht nicht frei. Il lavoro non ci rende liberi.
Qui una sintesi della loro introduzione al volume.
Come e perché siamo finiti a definire le nostre identità attraverso il lavoro, e a porlo come il fulcro volontario delle nostre esistenze? Perché abbiamo dovuto farne uno strumento legato alla soddisfazione personale e alla liberazione? Perché abbiamo voluto coprire la natura intrinsecamente forzata del lavoro chiamandola invece realizzazione?
Per la maggior parte della storia umana (…) si lavorava per necessità o coercizione, quasi mai per scelta, molto raramente con alacrità, se non sotto lo sguardo dei padroni. In effetti il compito più grande e arduo del primo capitalismo industriale è stato proprio trasformare l’orientamento umano al lavoro, radicato nei ritmi organici delle stagioni, in uno fondato sulla disciplina temporale non umana del regime di fabbrica.
(…) (Come) ha notato il saggista statunitense Robert Anton Wilson la maggior parte del lavoro nella nostra epoca è stupido e monotono, irritante e solitamente inutile e “consiste in sostanza nel processo agonizzante di annoiarsi a morte per un periodo di circa 40-45 anni di lavoro faticoso”.
(…)
L’epoca del lavorismo
Conosciamo un’infinità di trentenni, quarantenni e cinquantenni che vivono in città lavorocentriche e che sono in pieno burnout, esauriti dal lavoro. Eppure fanno a gara a chi lavora di più (e vive di meno). Dentro multinazionali dal sorriso affabile che in cambio dello status symbol offrono insensatezza, ipercompetizione, diritti sindacali inesistenti. E richiedono disponibilità temporale infinita, bloccati dentro città all’avanguardia in cui è sempre più complicato trovare un alloggio se non si è ricchi di famiglia.
Del lavorismo e dei suoi effetti parliamo anche in: Piccola enciclopedia medica del nuovo millennio. 1 WORKISM
La sindrome di Stoccolma aziendale
La sindrome di Stoccolma aziendale si manifesta attraverso un senso di lealtà e sottomissione ad un’azienda che, sotto le mentite spoglie della famiglia, finisce con il risucchiare tutte le energie, i sogni e le possibilità del dipendente. (…) Agiscono in buona sostanza come rapitrici dei lavoratori, non soltanto dal punto di vista delle ore che richiedono ai propri dipendenti, ma anche per ka devozione totalizzante che spingono ad assumere.
(…)
“Qui non abbiamo orari, ognuno può cominciare a lavorare quando vuole, c’è liberta!”, e poi tuti cominciano poco dopo l’alba e finiscono ben oltre il tramonto, perché banalmente sono costretti a lavorare il più possibile per ottemperare ai propri doveri, e l’assenza di orari si rivela nella sua vera natura di assenza di tutele.
(…)
E quante volte anche armato delle migliori intenzioni, finisca piuttosto per peggiorare le condizioni lavorative e psicofisiche dei propri dipendenti, per di più caricandoli di nuovi sensi di colpa: “Com’è possibile che nonostante tutti questi benefit tu ti senta insoddisfatto? Ingrato!”
(…)
La religione del lavoro
Jack Ma, fondatore di Alibaba, è un convinto sostenitore del 996, ossia del lavorare dalle 9 di mattina alle 9 di sera, per 6 giorni a settimana. (…) Chi lavora meno “non assaporerà mai la felicità e la ricompensa del duro lavoro”.
Il workism è quello strano spettacolo in cui assistiamo a persone apparentemente felici che dedicano molte più ore al lavoro rispetto a quelle per le quali erano state assunte. (…) Il lavoro si trasforma in questi casi sempre più diffusi in una fede religiosa perché promette identità trascendenza e comunità. Identità, perché produce una mission che ti dice chi sei, cosa vuoi, quali obiettivi devi avere nella vita. Trascendenza perché ti connette con una vision capace di dare senso (o più spesso di offrirne l’illusione). Comunità, perché genera un parco fedeli con cui condividere ed espandere il proprio trust e rinsaldare la relazione tossica.
(…)
Il lavoro come identità
Spiega Derek Thompson nel suo articolo Workism Is Making Americans Miserable, apparso il 24 febbraio 2019 su The Atlantic, che un numero crescente di persone in America lavora molto più di quanto facessero i loro coetanei dei decenni precedenti. (…) Allevati fin dall’adolescenza con la convinzione di dover fare della propria passione una carriera totalizzante e, in mancanza di una vera e propria vocazione, è stato detto loro di non arrendersi finché non ne avessero trovata una a cui dedicare ciecamente tutte le proprie energie.
(…) Cosa rappresenta oggi il lavoro: non soltanto un meccanismo di produzione economica, capace di generare uno stipendio con cui affrontare le spese quotidiane, ma sempre più il fulcro dell’identità e dello scopo della vita.
(…)
Secondo Thompson (…) venute meno le utopie religiose, sono nate e prosperate nuove religioni laiche. Tra queste il workism ha preso sempre più piede e ora sta al capitalismo come il cristianesimo è stato l’Impero di Costantino: uno strumento capillare dallo sguardo buono, funzionale a diffondere al meglio il verbo del sistema di potere in carica.
Un lavoro qualsiasi o un lavoro amato?
Intendiamoci: non c’è alcunché di sbagliato nel lavoro in sé; il problema risiede piuttosto nel fatto che è diventato un’ossessione. E sembra essere l’unico modo per dignificare la vita, ma si tratta di una possibilità valida soltanto per un numero esiguo di individui (…) La narrazione oggi imperante vuole dunque che la presenza e la produzione di senso passino esclusivamente attraverso l’ambito lavorativo. (…) Soltanto trasformando ogni lavoro qualsiasi in un lavoro amato si potranno trovare gioia, soddisfazione e realizzazione. (…) (Ma) non c’è niente di vero. La stragrande maggioranza dei lavori non garantisce la realizzazione personale. E la narrazione tossica diffusa per la quale sia il lavoro in sé a nobilitare l’umano non fa che produrre ansia e depressione in chi si colpevolizza per non riuscire a santificare la propria opera lavorativa.