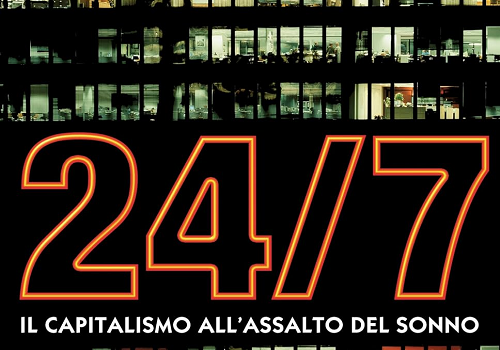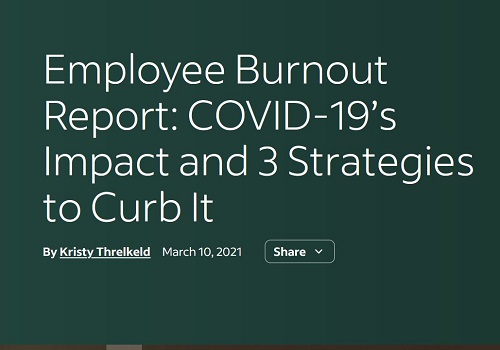Pubblico alcuni significativi estratti del terzo capitolo del libro di Andrea Colamedici e Maura Gancitano “Ma chi me lo fa fare”.
Qui una sintesi della loro introduzione al volume.
Qui alcuni estratti del primo capitolo.
Qui alcuni estratti del secondo capitolo.
La nostra società è fondata sul lavoro, perché il lavoro sembra avere significato in sé, non importa quale sia, e se abbia un fine. (…) La religione del lavoro è diventata progressivamente indubitabile universalmente condivisa.
Chi lavora tanto, chi si sacrifica – cioè sacrifica il proprio tempo, i propri interessi, le relazioni sociali – per il lavoro è una persona per cui scattano gli applausi, commozione e grande compassione, mentre chi si risparmia, passa il tempo a bighellonare, non usa le proprie capacità, sta compiendo un vero peccato sociale.
(…)
Ma quando abbiamo iniziato a dare tutta questa importanza all’idea di lavoro?
(…)
Secondo Hannah Arendt l’ascesa è cominciata nel Seicento quando Locke ha teorizzato che il lavoro fosse la fonte di ogni proprietà, è proseguita quando Adam Smith ha asserito che il lavoro è fonte di ogni ricchezza e ha trovato il suo culmine quando Karl Marx ha elaborato un sistema del lavoro.
(…)
La preoccupazione di Arendt (…) se esiste solo il lavoro, se il lavoro è la strada per accumulare benessere e benefit nel proprio privato, questo rischia di non lasciare spazio a tutto ciò che dà senso alla coesistenza umana.
(…)
È innegabile che la sensazione, oggi sempre più presente, è di vivere in un mondo caotico, di essere circondati da persone con cui non si condividono più le premesse fondamentali de vivere comune, (…), che sono interessate esclusivamente a se stesse e al proprio spazio privato, (alle proprie credenze, alla conferma delle proprie idee.
Del resto, quello che si fa ogni giorno sui social network, (…) si rovesciano sugli altri le proprie opinioni, (…) le esperienze individuali, senza riuscire a rispettare la molteplicità di vissuti e punti di vista.
Se però è facile vedere tutto questo negli altri, è più difficile vederlo in se stessi.
(…)
La società della performance
Abbiamo creato l’espressione società della perfomance (…): la spinta a mostrarci sempre attivi e produttivi, l’ansia da prestazione, unite alla paura di essere dimenticati, alla difficoltà di coltivare spazi vuoti, dilatare il tempo e mettere in pausa il rumore costante, alimentano l’insoddisfazione e la mancanza di senso della vita creando un circolo vizioso.
La continua produttività e il continuo consumo non danno senso, al massimo possono offrire un po’ di soddisfazione istantanea e volatile (…): fai un acquisto online e per un breve momento ti sembra di essere felice, ma poi ritorna quel senso di insoddisfazione.
Che fare dunque? Ovvio: acquistare qualche altra cosa per provare di nuovo un pizzico di contentezza momentanea.
La teologia del lavoro
Nel 1905, Max Weber pubblicò L’etica protestante e lo spirito del capitalismo.
(…) Nell’Europa del Nord in epoca moderna si era creata una congiuntura molto particolare. I calvinisti inglesi – detti puritani dai loro oppositori – erano una classe di artigiani e contadini che stava accumulando capitale e offriva lavoro.
(…)
I calvinisti spingevano le persone a adeguarsi ad una disciplina severa. (…) Il lavoro, in particolare, era il mezzo attraverso cui si poteva imparare la disciplina e diventare persone perbene, senza eccessi e grilli per l testa. Attraverso il lavoro si poteva dimostrare di saper stare al mondo, e quindi essere buoni cristiani.
(…)
Vangelo del lavoro e vangelo della ricchezza
Nella prima metà dell’Ottocento il filosofo scozzese di matrice calvinista Thomas Carlyle elaborò un vero e proprio Vangelo del lavoro, sostenendo (…) costituisse l’essenza stessa della vita. (…) Una vita di benessere era per pochi, la maggioranza doveva sviluppare il culto del dolore, saper portare la corona di spine, lavorare con sacrificio e ricordare sempre che da lì sarebbe arrivata la salvezza.
(…)
La ragione per cui molte idee economiche sono riuscite ad attecchire così tanto nella società e sono diventate dogmi (…) potrebbe dunque essere spiegata – almeno in parte – dal fatto che derivino da idee religiose.
L’idea di soffrire oggi, ma per una salvezza e un benessere futuri.
(…)
Solo qualche decennio più tardi, intorno al 1890, iniziò a diffondersi quello che Dimitra Doukas e Paul Durrenberg hanno chiamato Vangelo della ricchezza che, al contrario del Vangelo del lavoro, poneva il profitto al di sopra della fatica: si trattava della controffensiva culturale di banchieri, borghesi e industriali che intendevano contrastare l’idea che guadagnare senza faticare come un proletario significasse essere moralmente inferiori.
(…)
Il passaggio, sottolineato da molti antropologi, fu quello che traghettò la società del tempo dal produzionismo al consumismo: una persona ha valore sociale non se sa fare molte cose, ma se è in grado di acquistarle.